come gli scudetti della JuveSoTTO di nove ha scritto: ↑09/08/2024, 22:18Oggi nella pallanuoto plateale protesta azzurra che durante l'inno da le spalle al tavolo della giuria e poi, dopo aver conquistato il primo pallone (con la complicità degli spagnoli), chiama time out e decide di togliere dal match il giocatore che era stato accusato di fallo grave con l'Ungheria. (che avrebbero dovuto squalificare ma che invece era stato di fatto graziato, come se questo bastasse a farci ingoiare l'ingiustizia subita)
Se vinciamo due medaglie Malagò dirà che questa della Pallanuoto era la quarantesima.
[O.T.] Olimpiadi
Moderatori: Super Zeta, AlexSmith, Pim, Moderatore1
- federicoweb
- Storico dell'impulso
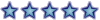
- Messaggi: 26852
- Iscritto il: 25/10/2007, 1:17
- Località: Milano
- Contatta:
Re: [O.T.] Olimpiadi
Chi non ha mai posseduto un cane, non sa cosa significhi essere amato ( Arthur Schopenhauer )
" Ste sgallettate che non sanno fare un cazzo e non partoriscono un concetto nemmeno sotto tortura
sono sacchi a pelo per il cazzo " ( Cit. ZETA )
" Ste sgallettate che non sanno fare un cazzo e non partoriscono un concetto nemmeno sotto tortura
sono sacchi a pelo per il cazzo " ( Cit. ZETA )
- federicoweb
- Storico dell'impulso
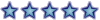
- Messaggi: 26852
- Iscritto il: 25/10/2007, 1:17
- Località: Milano
- Contatta:
Re: [O.T.] Olimpiadi
nel commento boxe di Damiani continuo a sentire l' azerbagiano anziche' Azero
arzerbagiano e' la lingua
ora c'e la finale con il trans
arzerbagiano e' la lingua
ora c'e la finale con il trans
Chi non ha mai posseduto un cane, non sa cosa significhi essere amato ( Arthur Schopenhauer )
" Ste sgallettate che non sanno fare un cazzo e non partoriscono un concetto nemmeno sotto tortura
sono sacchi a pelo per il cazzo " ( Cit. ZETA )
" Ste sgallettate che non sanno fare un cazzo e non partoriscono un concetto nemmeno sotto tortura
sono sacchi a pelo per il cazzo " ( Cit. ZETA )
- linebacker
- Veterano dell'impulso
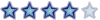
- Messaggi: 3226
- Iscritto il: 28/06/2009, 14:52
- Località: sempre più a fondo.
Re: [O.T.] Olimpiadi
no. a parte cose assurde, Crippa non ha speranze nella maratona.SoTTO di nove ha scritto: ↑09/08/2024, 22:22Che poi domattina c'è pure la maratona. Gelindo pare in gran forma.
A parte le battute sto Crippa che cambia distanza ha qualche speranza? Uh.
Mi spiace che abbiam perso Fibonacci, che avrebbe potuto dire molto al riguardo. Come mi dispiace che, rispetto al passato, abbiam perso, a parte pochi interventi, Parakarro (che, nei lanci, è il guru), Canella, l'uomo della boxe, Ben Dean, il computer umano e anche TD che, ogni tanto, qualche parola la metteva riguardo al basket.
- linebacker
- Veterano dell'impulso
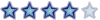
- Messaggi: 3226
- Iscritto il: 28/06/2009, 14:52
- Località: sempre più a fondo.
Re: [O.T.] Olimpiadi
dominio della Khalif. Come pugilato, e non come forza fisica, è incredibile. Come già detto, la rapidità delle braccia e la coordinazione sono incredibili. e quelle, non c'è testosterone che tenga. O li hai o non li hai. La cinese sembrava una macchinetta fatta per andare avanti e basta.
Persino dmiani, che non sarà un genio, ma è un medagliato olimpico ed è stato un buon professionista, nel primo round a velocità normale non si rndeva conto di quanti colpi che sembravano fuori, in realtà, erano a bersaglio. Te ne accorgi nel replay.
Persino dmiani, che non sarà un genio, ma è un medagliato olimpico ed è stato un buon professionista, nel primo round a velocità normale non si rndeva conto di quanti colpi che sembravano fuori, in realtà, erano a bersaglio. Te ne accorgi nel replay.
- linebacker
- Veterano dell'impulso
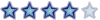
- Messaggi: 3226
- Iscritto il: 28/06/2009, 14:52
- Località: sempre più a fondo.
Re: [O.T.] Olimpiadi
hai pensato di spedire il curriculum a Jacopo Volpi? loro risparmiano un po' di stipendi, noi in un colpo solo abbiamo commenti sempre top e ci liberiamo di Chechi, Lucchetta, Cassani, Simona Rolandi ecc in un colpo solo.Drogato_ di_porno ha scritto: ↑09/08/2024, 21:56mi sa che ti stai confondendo con sotto e linebeckerhermafroditos ha scritto: ↑09/08/2024, 21:54Comunque non so voi ma sto amando immensamente le cronache di DDP, soprattutto lo ammiro per l'estrema disinvoltura con cui passa dai post - a volte ipercomplessi e documentati - di storia politica a ogni sport possibile e immaginabile.
DDP, ma ce l'hai la tessera del Mensa?
- Drogato_ di_porno
- Storico dell'impulso
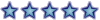
- Messaggi: 73982
- Iscritto il: 20/06/2002, 2:00
Re: [O.T.] Olimpiadi
io Chechi non lo reggo...5-10 minuti di battute va bene, dopo un'ora e mezza ho i conatilinebacker ha scritto: ↑09/08/2024, 23:19hai pensato di spedire il curriculum a Jacopo Volpi? loro risparmiano un po' di stipendi, noi in un colpo solo abbiamo commenti sempre top e ci liberiamo di Chechi, Lucchetta, Cassani, Simona Rolandi ecc in un colpo solo.
“Via, finito. L'ho dato via per l'America. L'ho regalato alla patria, alla democrazia. Così va meglio. A posto. Tutto bene. Ho donato il mio pisellino insensibile all'America. Ho donato il mio giovane pisellino alla democrazia. È perduto, non sente più nulla, finito chissà dove, là, vicino al fiume, fra le urla dell'artiglieria. Oh Dio, Dio, ridammelo! L'ho donato alla patria, l'ho immolato per tutto il paese. Ho dato il pisello per John Wayne e Howdy Doody, per Castiglia e Sparky il barbiere. Non mi ha mai detto nessuno che sarei tornato dalla guerra senza pene. Ma adesso sono tornato, la testa mi scoppia e non so cosa fare.” (Ron Kovic)
- linebacker
- Veterano dell'impulso
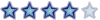
- Messaggi: 3226
- Iscritto il: 28/06/2009, 14:52
- Località: sempre più a fondo.
Re: [O.T.] Olimpiadi
due frazioni su 4 sono state pessime anche secondo i commentatori radio tv. con una prima frazione decente Tortu sarebbe partito con un vantaggio sufficente per il bronzo. Invece, dopo 40 metri lui ha mantenuto la velocità mentre gli altri sprintavano. Avevamo fatto dei cambi agli europei. Sicuramente non Ali, che è arrivato imballato alle semifinali dei 100.Forse Simonelli qualcosa avrebbe potuto dare, anche considerando la rabbia che aveva dopo il famoso penultimo ostacolo.DON CHISCIOTTE ha scritto: ↑09/08/2024, 20:06Sul corso male sono d’accordo…
Sui cambi non li ho visti tanto male, però parliamo sempre di una medaglia persa per 7 centesimi..
Un nulla…
A volte la prendi.. a volte la perdi…
Davanti alla tv siamo tutti professori…
- linebacker
- Veterano dell'impulso
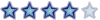
- Messaggi: 3226
- Iscritto il: 28/06/2009, 14:52
- Località: sempre più a fondo.
Re: [O.T.] Olimpiadi
appunto per quello saresti la nostra salvezza....Drogato_ di_porno ha scritto: ↑09/08/2024, 23:20io Chechi non lo reggo...5-10 minuti di battute va bene, dopo un'ora e mezza ho i conatilinebacker ha scritto: ↑09/08/2024, 23:19hai pensato di spedire il curriculum a Jacopo Volpi? loro risparmiano un po' di stipendi, noi in un colpo solo abbiamo commenti sempre top e ci liberiamo di Chechi, Lucchetta, Cassani, Simona Rolandi ecc in un colpo solo.
- Drogato_ di_porno
- Storico dell'impulso
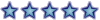
- Messaggi: 73982
- Iscritto il: 20/06/2002, 2:00
Re: [O.T.] Olimpiadi
bella finale nel beach femminile, le due brasiliane favorite hanno trovato filo da torcere con le canadesi, nel tie-break c'è pure stato un diverbio con ammonizioni che nel beach non si vede spesso
“Via, finito. L'ho dato via per l'America. L'ho regalato alla patria, alla democrazia. Così va meglio. A posto. Tutto bene. Ho donato il mio pisellino insensibile all'America. Ho donato il mio giovane pisellino alla democrazia. È perduto, non sente più nulla, finito chissà dove, là, vicino al fiume, fra le urla dell'artiglieria. Oh Dio, Dio, ridammelo! L'ho donato alla patria, l'ho immolato per tutto il paese. Ho dato il pisello per John Wayne e Howdy Doody, per Castiglia e Sparky il barbiere. Non mi ha mai detto nessuno che sarei tornato dalla guerra senza pene. Ma adesso sono tornato, la testa mi scoppia e non so cosa fare.” (Ron Kovic)
- SoTTO di nove
- Storico dell'impulso
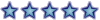
- Messaggi: 31206
- Iscritto il: 11/08/2011, 1:05
Re: [O.T.] Olimpiadi
Nel beach risultati strani.
La coppia canadese che ha vinto l'argento era passata come una delle migliori terze e anche nel maschile in finale ci sono arrivati gli svedesi ripescati dopo aver perso nel girone anche dalla coppia italiana. (qui probabile un altro oro tedesco)
Di solito non c'erano queste sorprese.
La coppia canadese che ha vinto l'argento era passata come una delle migliori terze e anche nel maschile in finale ci sono arrivati gli svedesi ripescati dopo aver perso nel girone anche dalla coppia italiana. (qui probabile un altro oro tedesco)
Di solito non c'erano queste sorprese.
Dòni, sa tirìa e cul indrìa, la capela la'n va avantei / Donne, se tirate il culo indietro, la cappella non va avanti. BITLIS
Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
- hermafroditos
- Storico dell'impulso
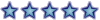
- Messaggi: 8645
- Iscritto il: 23/03/2022, 21:55
Re: [O.T.] Olimpiadi
Ancora con 'sta storia...comunque ha vinto, alla faccia tua, mentre a te non resta altro che ammazzarti di seghe a Borgomanero.
- SoTTO di nove
- Storico dell'impulso
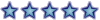
- Messaggi: 31206
- Iscritto il: 11/08/2011, 1:05
Re: [O.T.] Olimpiadi
Mah. Non sembra proprio così. La Khelif, come tutti, ha dovuto affinare le sue doti da boxere per emergere ma gli alti livelli di testosterone incidono eccome. Come avevo già fatto notare non conta nulla se vince o perde, quello dipende anche dalla tecnica che si impara nel tempo. Il punto è che di base ha mezzi superiori alle "donne con normali livelli di testosterone".linebacker ha scritto: ↑09/08/2024, 23:17dominio della Khalif. Come pugilato, e non come forza fisica, è incredibile. Come già detto, la rapidità delle braccia e la coordinazione sono incredibili. e quelle, non c'è testosterone che tenga. O li hai o non li hai. La cinese sembrava una macchinetta fatta per andare avanti e basta.
Persino dmiani, che non sarà un genio, ma è un medagliato olimpico ed è stato un buon professionista, nel primo round a velocità normale non si rndeva conto di quanti colpi che sembravano fuori, in realtà, erano a bersaglio. Te ne accorgi nel replay.
Quindi sgombrando il campo da tutto il bailame che ne è scaturito il livello di testosterone accettato dal CIO è stato probabilmente troppo permissivo. (considerando che anche scendere sotto una certa soglia quando l'ormone ha già "fatto il suo dovere" non inficia i vantaggi immagazzinati nel tempo)
L’ormone sessuale maschile diviene, quindi, protagonista di quanto fin qui esaminato: lavorare per incrementare i suoi livelli sierici, mediante un adeguato piano di sviluppo della Fmax, è fondamentale in quanto, come già affermato, questo ormone è connesso con la velocità dei movimenti, agendo da neuromodulatore e favorendo la fenotipizzazione delle fibre veloci, la conseguenza è direttamente coinvolta nelle manifestazioni esplosive della forza. Il testosterone agisce anche stabilizzando le pompe del calcio, rendendole meno perturbate dall’abbassamento del pH ematico dovuto alla produzione dell’acido lattico (conseguenza della reiterazione della FE), rappresentando un fattore affatto trascurabile negli sport in cui la RFV è determinante la relazione fra Testosterone e l'allenamento nel pugilato
[Scopri]Spoiler
RESISTENZA ALLA FORZA VELOCE
Nel pugilato, infatti, nel corso di una ripresa, l’atleta porta delle combinazioni di colpi in attacco o in contrattacco (FE) che sono, spesso,seguite da fasi a distanza di studio tattico o di difesa dall’attacco avversario mediante l’utilizzo delle schivate; e non è raro vedere i due pugili, soprattutto alla fine di un intenso scambio di colpi, legare.
Legare, gestire lo stress, difendersi e studiare l’avversario, oltre a rappresentare degli utili strumenti tattici, rappresentano anche delle fasi di recupero che seguono e precedono le interazioni oppositore con l’avversario; inoltre, alla fine di ogni ripresa, il regolamento prevede un minuto di pausa prima di proseguire Il problema principale a cui deve rispondere il pugile durante la competizione è sempre lo stesso: spostarsi rapidamente, colpire rapidamente, recuperare velocemente la posizione difensiva/offensiva (guardia). In altre parole, mentre l’atleta attacca, pensa alla difesa o, se si difende,pensa al contrattacco.
Se nella boxe bisogna reiterare azioni di forza esplosiva, è chiaro che quest’ultima è la qualità più importante. Bisogna, però, operare una distinzione: questo tipo di FE non è come quella del saltatore in alto, il quale fa solo una prestazione e poi ha un tempo di recupero di circa dieci minuti prima di eseguire un nuovo salto. Nel pugilato, occorre esprime azioni efficaci grazie all’utilizzo della FE e dei meccanismi energetici che la sostengono; occorre, inoltre, cercare di conservare nel tempo la stessa
capacità. L’allenamento specifico consentirà di ripristinare i meccanismi energetici adeguati nel più breve tempo possibile. Lo scopo fondamentale dell’allenamento è quello di migliorare la capacità di resistenza alla fatica .
Nella pratica i parametri da rispettare per lo sviluppo della RFV sono:
– i carichi da utilizzare si aggirano tra il 20% ed il 50% del CM
– il numero delle ripetizioni deve essere tale da non permettere una riduzione della potenza massima superiore al 20%,
Altrimenti, il numero delle ripetizioni deve essere tale da essere eseguito in un intervallo di tempo che va dai 15 ai 45 secondi sconsigliato utilizzare, all’inizio delle serie (che hanno durata superiore ai 20 secondi),
potenze superiori al 90% al fine di evitare l’insorgenza precoce della fatica.
Secondo Bosco il miglioramento della forza massimale, della FE e della RFV deve avvenire non a tappe ma in contemporanea. Questo perché si cerca di sfruttare le forti correlazioni che esistono
tra Fmax, FE e RFV Il concetto di base di questo metodo è quello di stimolare nello stesso tempo più proprietà biologiche, per migliorarne le capacità funzionali
Il testosterone è un ormone indispensabile non solo per la FE ma è anche fondamentale nella resistenza alla forza veloce. La capacità di reiterare la forza esplosiva è collegata all’entità del T
Infatti, la presenza elevata di testosterone favorirebbe, a livello cellulare, una migliore funzione biochimica e meccanica del muscolo. Il T potenzierebbe l’attività della pompa del calcio (C a 2+),
favorendo lo sviluppo di elevati gradienti di potenza muscolare, rendendo la pompa del calcio meno perturbata dall’abbassamento del pH indotto dall’aumento della produzione di acido lattico (AL).
L’acido lattico rappresenta il fattore che limita la reiterazione della FE e che, quindi, determina L’insorgenza della fatica a cui, con l’allenamento, si deve aumentare la tolleranza.
Lavorare con la forza massimale, serve proprio per fare in modo che ci siano nell’atleta alti
livelli di T circolante, in quanto con alti livelli di T circolante si favorirebbe la fenotipizzazione delle fibre veloci e il soggetto migliorerebbe la velocità. Migliorare la velocità significa aumentare la RFV, perché questa è connessa alla velocità massimale.
Maggiore è la capacità di FE, migliore è la capacità del soggetto di resistere alla forza veloce e reiterarla nel tempo, in quanto connessa alla capacità di reclutare un elevato numero di FT (Bosco,1997)
Le ricerche di Bosco nell’ambito dell’allenamento della RFV hanno dimostrato che questa non ha alcuna correlazione con l’efficienza del metabolismo aerobico.
Questo suggerisce che i processi di generazione di energia biochimica coinvolti in prestazioni massimali che non durano più di un minuto, sono scarsamente influenzati dalle capacità aerobiche dell’atleta: questi processi non rappresentano un fattore limitante per l’esecuzione del lavoro stata osservata una relazione inversa tra la potenza aerobica e la concentrazione di T: negli atleti che possiedono una migliore potenza aerobica, il livello di T è più basso L’aumento di questi ormoni, conseguenza di allenamenti aerobici protratti nel tempo, permette di sopportare con maggiore facilità la fatica ed il lavoro strenuo, tanto da provocare un senso di benessere generale chiamato “euforia del corridore”.
Nello stesso tempo, una concentrazione elevata di ß-endorfine inibirebbe l’ormone luteinizzante
(LH) che, a sua volta, cesserebbe di stimolare le gonadi a produrre testosterone.
Allenamenti che a livello muscolare determinano una trasmissione di impulsi a bassa frequenza Quanto detto, ci deve far riflettere sull’opportunità dell’utilizzo di allenamenti per la potenza aerobica in specialità dove la FE e la RFV sono poi le capacità che maggiormente determinano la prestazione, così come nel pugilato.
Quindi, nella pratica, esercitazioni di corsa lenta e prolungata (fondo) potrebbero essere evitate da parte del pugile, Nel caso si voglia comunque praticare questo tipo di esercitazioni effettuare variazioni di velocità, salti e balzi durante la corsa; questo permette l’aumento della capacità aerobica e, parallelamente, un incremento di FE (degli arti inferiori).
Proprio l’eliminazione di stimoli prodotti a bassa frequenza (corsa lenta, eccesso di riprese al sacco, ecc.) rappresenta già un fattore positivo in grado di migliorare le capacità di forza dinamica massima
Ricordiamo che l’allenamento specifico prevede sollecitazioni massimali delle proprietà
fisiologiche da sviluppare che vanno contro l’enfasi della quantità.
Il pugilato è e rimane uno sport di situazione, aciclico, che non ha bisogno di stimoli ciclici che in
parte mortificherebbero il sistema nervoso.
Bisogna allenare il pugile esaltando proprio la sua condizione neuromuscolare che lo porta a continui adattamenti all’avversario che agisce.
Mezzi e metodi per l’allenamento della RFV
L’Interval Training
ripetizione di colpi al sacco → 8 secondi al massimo della velocità, seguiti da 20 sec. di recupero passivo (eseguire da due a quattro serie, da 15 ripetizioni ciascuna) il recupero tra
ogni serie verrà stabilito da 3 minuti a 60 sec. in relazione al grado di preparazione dell’atleta e al suo livello specifico di esperienza con questo tipo di esercitazione).
ripetizione di colpi al sacco → 30 sec. al 90 % della velocità massima, seguiti da 30
sec. di recupero passivo (eseguire una o due serie da 6 rip. ciascuna, intervallate da 1 minuto di recupero).
E’ importante sottolineare che nel primo caso, i colpi portati al sacco negli otto secondi, devono sempre essere eseguiti al massimo delle possibilità
Nel secondo caso, i 30 secondi di attività vanno eseguiti non superando, all’inizio della
ripetizione, il 90% della potenza massima, per non generare precocemente fatica e, quindi,
invalidare l’allenamento.
Nel pugilato, infatti, nel corso di una ripresa, l’atleta porta delle combinazioni di colpi in attacco o in contrattacco (FE) che sono, spesso,seguite da fasi a distanza di studio tattico o di difesa dall’attacco avversario mediante l’utilizzo delle schivate; e non è raro vedere i due pugili, soprattutto alla fine di un intenso scambio di colpi, legare.
Legare, gestire lo stress, difendersi e studiare l’avversario, oltre a rappresentare degli utili strumenti tattici, rappresentano anche delle fasi di recupero che seguono e precedono le interazioni oppositore con l’avversario; inoltre, alla fine di ogni ripresa, il regolamento prevede un minuto di pausa prima di proseguire Il problema principale a cui deve rispondere il pugile durante la competizione è sempre lo stesso: spostarsi rapidamente, colpire rapidamente, recuperare velocemente la posizione difensiva/offensiva (guardia). In altre parole, mentre l’atleta attacca, pensa alla difesa o, se si difende,pensa al contrattacco.
Se nella boxe bisogna reiterare azioni di forza esplosiva, è chiaro che quest’ultima è la qualità più importante. Bisogna, però, operare una distinzione: questo tipo di FE non è come quella del saltatore in alto, il quale fa solo una prestazione e poi ha un tempo di recupero di circa dieci minuti prima di eseguire un nuovo salto. Nel pugilato, occorre esprime azioni efficaci grazie all’utilizzo della FE e dei meccanismi energetici che la sostengono; occorre, inoltre, cercare di conservare nel tempo la stessa
capacità. L’allenamento specifico consentirà di ripristinare i meccanismi energetici adeguati nel più breve tempo possibile. Lo scopo fondamentale dell’allenamento è quello di migliorare la capacità di resistenza alla fatica .
Nella pratica i parametri da rispettare per lo sviluppo della RFV sono:
– i carichi da utilizzare si aggirano tra il 20% ed il 50% del CM
– il numero delle ripetizioni deve essere tale da non permettere una riduzione della potenza massima superiore al 20%,
Altrimenti, il numero delle ripetizioni deve essere tale da essere eseguito in un intervallo di tempo che va dai 15 ai 45 secondi sconsigliato utilizzare, all’inizio delle serie (che hanno durata superiore ai 20 secondi),
potenze superiori al 90% al fine di evitare l’insorgenza precoce della fatica.
Secondo Bosco il miglioramento della forza massimale, della FE e della RFV deve avvenire non a tappe ma in contemporanea. Questo perché si cerca di sfruttare le forti correlazioni che esistono
tra Fmax, FE e RFV Il concetto di base di questo metodo è quello di stimolare nello stesso tempo più proprietà biologiche, per migliorarne le capacità funzionali
Il testosterone è un ormone indispensabile non solo per la FE ma è anche fondamentale nella resistenza alla forza veloce. La capacità di reiterare la forza esplosiva è collegata all’entità del T
Infatti, la presenza elevata di testosterone favorirebbe, a livello cellulare, una migliore funzione biochimica e meccanica del muscolo. Il T potenzierebbe l’attività della pompa del calcio (C a 2+),
favorendo lo sviluppo di elevati gradienti di potenza muscolare, rendendo la pompa del calcio meno perturbata dall’abbassamento del pH indotto dall’aumento della produzione di acido lattico (AL).
L’acido lattico rappresenta il fattore che limita la reiterazione della FE e che, quindi, determina L’insorgenza della fatica a cui, con l’allenamento, si deve aumentare la tolleranza.
Lavorare con la forza massimale, serve proprio per fare in modo che ci siano nell’atleta alti
livelli di T circolante, in quanto con alti livelli di T circolante si favorirebbe la fenotipizzazione delle fibre veloci e il soggetto migliorerebbe la velocità. Migliorare la velocità significa aumentare la RFV, perché questa è connessa alla velocità massimale.
Maggiore è la capacità di FE, migliore è la capacità del soggetto di resistere alla forza veloce e reiterarla nel tempo, in quanto connessa alla capacità di reclutare un elevato numero di FT (Bosco,1997)
Le ricerche di Bosco nell’ambito dell’allenamento della RFV hanno dimostrato che questa non ha alcuna correlazione con l’efficienza del metabolismo aerobico.
Questo suggerisce che i processi di generazione di energia biochimica coinvolti in prestazioni massimali che non durano più di un minuto, sono scarsamente influenzati dalle capacità aerobiche dell’atleta: questi processi non rappresentano un fattore limitante per l’esecuzione del lavoro stata osservata una relazione inversa tra la potenza aerobica e la concentrazione di T: negli atleti che possiedono una migliore potenza aerobica, il livello di T è più basso L’aumento di questi ormoni, conseguenza di allenamenti aerobici protratti nel tempo, permette di sopportare con maggiore facilità la fatica ed il lavoro strenuo, tanto da provocare un senso di benessere generale chiamato “euforia del corridore”.
Nello stesso tempo, una concentrazione elevata di ß-endorfine inibirebbe l’ormone luteinizzante
(LH) che, a sua volta, cesserebbe di stimolare le gonadi a produrre testosterone.
Allenamenti che a livello muscolare determinano una trasmissione di impulsi a bassa frequenza Quanto detto, ci deve far riflettere sull’opportunità dell’utilizzo di allenamenti per la potenza aerobica in specialità dove la FE e la RFV sono poi le capacità che maggiormente determinano la prestazione, così come nel pugilato.
Quindi, nella pratica, esercitazioni di corsa lenta e prolungata (fondo) potrebbero essere evitate da parte del pugile, Nel caso si voglia comunque praticare questo tipo di esercitazioni effettuare variazioni di velocità, salti e balzi durante la corsa; questo permette l’aumento della capacità aerobica e, parallelamente, un incremento di FE (degli arti inferiori).
Proprio l’eliminazione di stimoli prodotti a bassa frequenza (corsa lenta, eccesso di riprese al sacco, ecc.) rappresenta già un fattore positivo in grado di migliorare le capacità di forza dinamica massima
Ricordiamo che l’allenamento specifico prevede sollecitazioni massimali delle proprietà
fisiologiche da sviluppare che vanno contro l’enfasi della quantità.
Il pugilato è e rimane uno sport di situazione, aciclico, che non ha bisogno di stimoli ciclici che in
parte mortificherebbero il sistema nervoso.
Bisogna allenare il pugile esaltando proprio la sua condizione neuromuscolare che lo porta a continui adattamenti all’avversario che agisce.
Mezzi e metodi per l’allenamento della RFV
L’Interval Training
ripetizione di colpi al sacco → 8 secondi al massimo della velocità, seguiti da 20 sec. di recupero passivo (eseguire da due a quattro serie, da 15 ripetizioni ciascuna) il recupero tra
ogni serie verrà stabilito da 3 minuti a 60 sec. in relazione al grado di preparazione dell’atleta e al suo livello specifico di esperienza con questo tipo di esercitazione).
ripetizione di colpi al sacco → 30 sec. al 90 % della velocità massima, seguiti da 30
sec. di recupero passivo (eseguire una o due serie da 6 rip. ciascuna, intervallate da 1 minuto di recupero).
E’ importante sottolineare che nel primo caso, i colpi portati al sacco negli otto secondi, devono sempre essere eseguiti al massimo delle possibilità
Nel secondo caso, i 30 secondi di attività vanno eseguiti non superando, all’inizio della
ripetizione, il 90% della potenza massima, per non generare precocemente fatica e, quindi,
invalidare l’allenamento.
@ Herma, al netto di come la si può pensare nei fatti ha vinto alla faccia delle altre. Per te sarà anche giusto perchè "inclusivo" per altri, comprese molte sportive che queste scelte le subiscono, no.
Dòni, sa tirìa e cul indrìa, la capela la'n va avantei / Donne, se tirate il culo indietro, la cappella non va avanti. BITLIS
Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
- lider maximo
- Storico dell'impulso
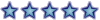
- Messaggi: 16615
- Iscritto il: 22/06/2013, 0:01
- Località: In giro da qualche parte con tre bottiglie 3 di birra in mano.
Re: [O.T.] Olimpiadi
Semplicemente patetici.SoTTO di nove ha scritto: ↑09/08/2024, 22:18Oggi nella pallanuoto plateale protesta azzurra che durante l'inno da le spalle al tavolo della giuria e poi, dopo aver conquistato il primo pallone (con la complicità degli spagnoli), chiama time out e decide di togliere dal match il giocatore che era stato accusato di fallo grave con l'Ungheria. (che avrebbero dovuto squalificare ma che invece era stato di fatto graziato, come se questo bastasse a farci ingoiare l'ingiustizia subita)
Se vinciamo due medaglie Malagò dirà che questa della Pallanuoto era la quarantesima.
Erano avanti di due reti per più di un tempo (6-4 7-5 8-6) ergo avevano tutte le possibilità di vincere aldilà dei possibili errori arbitrali. E' da perdenti appellarsi agli arbitri per giustificare una sconfitta.
Ancora con questa storia tutta ITALIANA di valutare il lavoro fatto in base al risultato puro e semplice, in base al peso della medaglia, etc etc., senza tenere conto degli avversari, delle avversità che si possono incontrare (vedi Tamberi), dei dettagli che possono girare contro nella giornata clou (vedi Simonelli con l'ostacolo), etc etc..cicciuzzo ha scritto: ↑09/08/2024, 13:30
Mi dispiace, ma conoscete poco quello che sta muovendo l'atletica italiana come movimento da tokyo in poi. Parlo di tecnici, di federazione, di sponsor e quindi di soldi. Quello che è successo agli europei e prima ancora agli europei a squadre è roba potente e non casuale. In soldoni a Parigi dovevamo fare non bene ma molto bene ed il primo a dirlo sarà Mei visto che ormai è conclamato che si torni a casa con un misero bronzo. Con questo non dico che bisogna dare addosso agli atleti ma quando leggi da ambienti federali che il tempo fatto da Simonelli a Rona qui a Parigi sarebbe stato argento fa capire la delusione patita. Non metti Tamberi porta bandiera se non punti a grossi risultati
Poi spero di essere smentito e sia la 4x100 che Tamberi vadano a medaglia. Non sono un runner ed esperto di all'etica importante come Fibonacci ma in questi anni sto seguendo tantissimo quello che succede e so gli sforzi dell'intero movimento
Ps: anche se il miracolo per eccellenza sarebbe Nadia nei 10mila
Quello che si dovrebbe valutare, prima di tutto, sono i percorsi fatti dai singoli atleti per arrivare alle olimpiadi preparati, che si dia tutto il giorno delle gare, e solo in seconda battuta il risultato. Questo dovrebbe valere in tutti gli sport, di squadra e individuali.
E invece ci si fossilizza solo sul risultato. Non si prendono gli stessi ori di Tokyo, spedizione deludente, o peggio fallimentare direbbe qualcun'altro. Tutte cazzate, per me il bilancio è più che positivo, tantissimi atleti competitivi, che fanno finali, record personali/italiani, poi se prendi il metallo bene, altrimenti bona lo stesso.
E nel frattempo prese altre due medaglie, quella di Nadia è un mezzo oro, 10 centesimi sui 10000.
#ALLEGRIOUT(dal calcio) non è importante, è l'unica cosa che conta.
- SoTTO di nove
- Storico dell'impulso
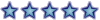
- Messaggi: 31206
- Iscritto il: 11/08/2011, 1:05
Re: [O.T.] Olimpiadi
è come dire che il Milan non si doveva lamentare del gol di Muntari perchè comunque era già in vantaggio. Ci sono errori che impattano molto di più di altri.lider maximo ha scritto: ↑10/08/2024, 0:13Semplicemente patetici.SoTTO di nove ha scritto: ↑09/08/2024, 22:18Oggi nella pallanuoto plateale protesta azzurra che durante l'inno da le spalle al tavolo della giuria e poi, dopo aver conquistato il primo pallone (con la complicità degli spagnoli), chiama time out e decide di togliere dal match il giocatore che era stato accusato di fallo grave con l'Ungheria. (che avrebbero dovuto squalificare ma che invece era stato di fatto graziato, come se questo bastasse a farci ingoiare l'ingiustizia subita)
Se vinciamo due medaglie Malagò dirà che questa della Pallanuoto era la quarantesima.
Erano avanti di due reti per più di un tempo (6-4 7-5 8-6) ergo avevano tutte le possibilità di vincere aldilà dei possibili errori arbitrali. E' da perdenti appellarsi agli arbitri per giustificare una sconfitta.
Li gli è stato tolto un gol, l'hanno di fatto regalato agli ungheresi (beffa doppia) e hanno dovuto giocare 4 minuti (tantissimi nella pallanuoto) in inferiorità numerica sprecando tantissime energie che sono venute a mancare nel finale.
Dòni, sa tirìa e cul indrìa, la capela la'n va avantei / Donne, se tirate il culo indietro, la cappella non va avanti. BITLIS
Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
- linebacker
- Veterano dell'impulso
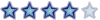
- Messaggi: 3226
- Iscritto il: 28/06/2009, 14:52
- Località: sempre più a fondo.
Re: [O.T.] Olimpiadi
non concordo. ma è giusto così. abbiamo due punti di vista diversi. tutto qui.SoTTO di nove ha scritto: ↑10/08/2024, 0:04Mah. Non sembra proprio così. La Khelif, come tutti, ha dovuto affinare le sue doti da boxere per emergere ma gli alti livelli di testosterone incidono eccome. Come avevo già fatto notare non conta nulla se vince o perde, quello dipende anche dalla tecnica che si impara nel tempo. Il punto è che di base ha mezzi superiori alle "donne con normali livelli di testosterone".linebacker ha scritto: ↑09/08/2024, 23:17dominio della Khalif. Come pugilato, e non come forza fisica, è incredibile. Come già detto, la rapidità delle braccia e la coordinazione sono incredibili. e quelle, non c'è testosterone che tenga. O li hai o non li hai. La cinese sembrava una macchinetta fatta per andare avanti e basta.
Persino dmiani, che non sarà un genio, ma è un medagliato olimpico ed è stato un buon professionista, nel primo round a velocità normale non si rndeva conto di quanti colpi che sembravano fuori, in realtà, erano a bersaglio. Te ne accorgi nel replay.
Quindi sgombrando il campo da tutto il bailame che ne è scaturito il livello di testosterone accettato dal CIO è stato probabilmente troppo permissivo. (considerando che anche scendere sotto una certa soglia quando l'ormone ha già "fatto il suo dovere" non inficia i vantaggi immagazzinati nel tempo)L’ormone sessuale maschile diviene, quindi, protagonista di quanto fin qui esaminato: lavorare per incrementare i suoi livelli sierici, mediante un adeguato piano di sviluppo della Fmax, è fondamentale in quanto, come già affermato, questo ormone è connesso con la velocità dei movimenti, agendo da neuromodulatore e favorendo la fenotipizzazione delle fibre veloci, la conseguenza è direttamente coinvolta nelle manifestazioni esplosive della forza. Il testosterone agisce anche stabilizzando le pompe del calcio, rendendole meno perturbate dall’abbassamento del pH ematico dovuto alla produzione dell’acido lattico (conseguenza della reiterazione della FE), rappresentando un fattore affatto trascurabile negli sport in cui la RFV è determinante la relazione fra Testosterone e l'allenamento nel pugilatoNon credo esistano sport dove un'alta differenza di testosterone sia più impattante che non nella Boxe. (ovviamente poi bisogna anche saper boxare, io con livelli di testosterone belli alti ci perderei con le donne che fanno pugilato)[Scopri]SpoilerRESISTENZA ALLA FORZA VELOCE
Nel pugilato, infatti, nel corso di una ripresa, l’atleta porta delle combinazioni di colpi in attacco o in contrattacco (FE) che sono, spesso,seguite da fasi a distanza di studio tattico o di difesa dall’attacco avversario mediante l’utilizzo delle schivate; e non è raro vedere i due pugili, soprattutto alla fine di un intenso scambio di colpi, legare.
Legare, gestire lo stress, difendersi e studiare l’avversario, oltre a rappresentare degli utili strumenti tattici, rappresentano anche delle fasi di recupero che seguono e precedono le interazioni oppositore con l’avversario; inoltre, alla fine di ogni ripresa, il regolamento prevede un minuto di pausa prima di proseguire Il problema principale a cui deve rispondere il pugile durante la competizione è sempre lo stesso: spostarsi rapidamente, colpire rapidamente, recuperare velocemente la posizione difensiva/offensiva (guardia). In altre parole, mentre l’atleta attacca, pensa alla difesa o, se si difende,pensa al contrattacco.
Se nella boxe bisogna reiterare azioni di forza esplosiva, è chiaro che quest’ultima è la qualità più importante. Bisogna, però, operare una distinzione: questo tipo di FE non è come quella del saltatore in alto, il quale fa solo una prestazione e poi ha un tempo di recupero di circa dieci minuti prima di eseguire un nuovo salto. Nel pugilato, occorre esprime azioni efficaci grazie all’utilizzo della FE e dei meccanismi energetici che la sostengono; occorre, inoltre, cercare di conservare nel tempo la stessa
capacità. L’allenamento specifico consentirà di ripristinare i meccanismi energetici adeguati nel più breve tempo possibile. Lo scopo fondamentale dell’allenamento è quello di migliorare la capacità di resistenza alla fatica .
Nella pratica i parametri da rispettare per lo sviluppo della RFV sono:
– i carichi da utilizzare si aggirano tra il 20% ed il 50% del CM
– il numero delle ripetizioni deve essere tale da non permettere una riduzione della potenza massima superiore al 20%,
Altrimenti, il numero delle ripetizioni deve essere tale da essere eseguito in un intervallo di tempo che va dai 15 ai 45 secondi sconsigliato utilizzare, all’inizio delle serie (che hanno durata superiore ai 20 secondi),
potenze superiori al 90% al fine di evitare l’insorgenza precoce della fatica.
Secondo Bosco il miglioramento della forza massimale, della FE e della RFV deve avvenire non a tappe ma in contemporanea. Questo perché si cerca di sfruttare le forti correlazioni che esistono
tra Fmax, FE e RFV Il concetto di base di questo metodo è quello di stimolare nello stesso tempo più proprietà biologiche, per migliorarne le capacità funzionali
Il testosterone è un ormone indispensabile non solo per la FE ma è anche fondamentale nella resistenza alla forza veloce. La capacità di reiterare la forza esplosiva è collegata all’entità del T
Infatti, la presenza elevata di testosterone favorirebbe, a livello cellulare, una migliore funzione biochimica e meccanica del muscolo. Il T potenzierebbe l’attività della pompa del calcio (C a 2+),
favorendo lo sviluppo di elevati gradienti di potenza muscolare, rendendo la pompa del calcio meno perturbata dall’abbassamento del pH indotto dall’aumento della produzione di acido lattico (AL).
L’acido lattico rappresenta il fattore che limita la reiterazione della FE e che, quindi, determina L’insorgenza della fatica a cui, con l’allenamento, si deve aumentare la tolleranza.
Lavorare con la forza massimale, serve proprio per fare in modo che ci siano nell’atleta alti
livelli di T circolante, in quanto con alti livelli di T circolante si favorirebbe la fenotipizzazione delle fibre veloci e il soggetto migliorerebbe la velocità. Migliorare la velocità significa aumentare la RFV, perché questa è connessa alla velocità massimale.
Maggiore è la capacità di FE, migliore è la capacità del soggetto di resistere alla forza veloce e reiterarla nel tempo, in quanto connessa alla capacità di reclutare un elevato numero di FT (Bosco,1997)
Le ricerche di Bosco nell’ambito dell’allenamento della RFV hanno dimostrato che questa non ha alcuna correlazione con l’efficienza del metabolismo aerobico.
Questo suggerisce che i processi di generazione di energia biochimica coinvolti in prestazioni massimali che non durano più di un minuto, sono scarsamente influenzati dalle capacità aerobiche dell’atleta: questi processi non rappresentano un fattore limitante per l’esecuzione del lavoro stata osservata una relazione inversa tra la potenza aerobica e la concentrazione di T: negli atleti che possiedono una migliore potenza aerobica, il livello di T è più basso L’aumento di questi ormoni, conseguenza di allenamenti aerobici protratti nel tempo, permette di sopportare con maggiore facilità la fatica ed il lavoro strenuo, tanto da provocare un senso di benessere generale chiamato “euforia del corridore”.
Nello stesso tempo, una concentrazione elevata di ß-endorfine inibirebbe l’ormone luteinizzante
(LH) che, a sua volta, cesserebbe di stimolare le gonadi a produrre testosterone.
Allenamenti che a livello muscolare determinano una trasmissione di impulsi a bassa frequenza Quanto detto, ci deve far riflettere sull’opportunità dell’utilizzo di allenamenti per la potenza aerobica in specialità dove la FE e la RFV sono poi le capacità che maggiormente determinano la prestazione, così come nel pugilato.
Quindi, nella pratica, esercitazioni di corsa lenta e prolungata (fondo) potrebbero essere evitate da parte del pugile, Nel caso si voglia comunque praticare questo tipo di esercitazioni effettuare variazioni di velocità, salti e balzi durante la corsa; questo permette l’aumento della capacità aerobica e, parallelamente, un incremento di FE (degli arti inferiori).
Proprio l’eliminazione di stimoli prodotti a bassa frequenza (corsa lenta, eccesso di riprese al sacco, ecc.) rappresenta già un fattore positivo in grado di migliorare le capacità di forza dinamica massima
Ricordiamo che l’allenamento specifico prevede sollecitazioni massimali delle proprietà
fisiologiche da sviluppare che vanno contro l’enfasi della quantità.
Il pugilato è e rimane uno sport di situazione, aciclico, che non ha bisogno di stimoli ciclici che in
parte mortificherebbero il sistema nervoso.
Bisogna allenare il pugile esaltando proprio la sua condizione neuromuscolare che lo porta a continui adattamenti all’avversario che agisce.
Mezzi e metodi per l’allenamento della RFV
L’Interval Training
ripetizione di colpi al sacco → 8 secondi al massimo della velocità, seguiti da 20 sec. di recupero passivo (eseguire da due a quattro serie, da 15 ripetizioni ciascuna) il recupero tra
ogni serie verrà stabilito da 3 minuti a 60 sec. in relazione al grado di preparazione dell’atleta e al suo livello specifico di esperienza con questo tipo di esercitazione).
ripetizione di colpi al sacco → 30 sec. al 90 % della velocità massima, seguiti da 30
sec. di recupero passivo (eseguire una o due serie da 6 rip. ciascuna, intervallate da 1 minuto di recupero).
E’ importante sottolineare che nel primo caso, i colpi portati al sacco negli otto secondi, devono sempre essere eseguiti al massimo delle possibilità
Nel secondo caso, i 30 secondi di attività vanno eseguiti non superando, all’inizio della
ripetizione, il 90% della potenza massima, per non generare precocemente fatica e, quindi,
invalidare l’allenamento.
@ Herma, al netto di come la si può pensare nei fatti ha vinto alla faccia delle altre. Per te sarà anche giusto perchè "inclusivo" per altri, comprese molte sportive che queste scelte le subiscono, no.
