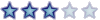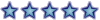Gentile Professore,
Innanzitutto mi presento: sono Matteo Molinari, ed ho collaborato alla serie Anche le Formiche nel Loro Piccolo S’incazzano per quasi 20 anni. Non dovesse credermi, come del resto ha fatto quasi tutta Italia fin dall’inizio, la invito a controllare e vedrà che sotto ai nomi di Gino & Michele il più delle volte appare anche il mio.
Sto seguendo da qualche settimana dalla soleggiata California la polemica che la riguarda, quella che, immagino avrà sentito, la accusa di aver copiato materiale da comedian d’oltremanica e d’oltreoceano.
Anzi, in realtà le scrivo perché ho appena letto la sua intervista su Il Fatto Quotidiano, ove tra le altre cose lei ha detto (mi permetto di citarla, anzi metto il testo tra virgolette e lo scrivo in corsivo – giammai vorrei essere accusato di plagiare interviste altrui): “A me non diverte far ridere con battute altrui, quelle che cito (celeberrime, e di autori di cui parlo sempre nei miei libri e nelle interviste) le uso per i miei esperimenti sulla comicità: le modifiche che apporto possono sembrare irrilevanti a chi non è pratico, ma per un comico sono sostanziali, se potenziano l’efficacia della battuta. L’attacco diffamatorio contro di me, però, è maldestro, soprattutto dal punto di vista tecnico: si tratta di qualcuno che non conosce i fondamenti della semiotica, e della comunicazione comica in particolare.”
Ora, avendo io tradotto quasi tutte le battute delle Formiche che provenivano dall’America e dall’Inghilterra, probabilmente non sarò un laureato in semiotica (anzi – sicuramente non sono un laureato in semiotica, a meno che non abbia ricevuto un diploma per sbaglio, ma non mi pare), però qualcosetta sulla comunicazione comica credo di saperla. Del resto, le Formiche hanno venduto qualche milione di copia (frase di autoincensatura, me ne rendo conto), e fino ad ora non ho ancora ricevuto una lettera che mi diceva, “Come ha osato tradurre così quella tal battuta, quando sarebbe stata meglio cosà?! Lei chiaramente non conosce i fondamenti della semiotica e della comunicazione comica in particolare!” (se mai qualcuno me l’avesse scritta, non mi è pervenuta, per cui colgo l’occasione per scusarmene in codesta sede).
Non entro nel merito della sua dichiarazione fatta su Repubblica nel lontano 2001 sull’originalità di tutte le battute di Satyricon, ma mi punge vaghezza: quanti esperimenti sulla comicità ha condotto, finora, per usare tutte quelle battute? Si possono conoscere i risultati di detti esperimenti? E, se le battute che lei cita sono (a detta sua) “celeberrime,” perché se la prende tanto con il video da lei bollato come diffamatorio che sta circolando online? Se sono celeberrime, e lei dice che cita queste battute, come fa esattamente il video ad essere diffamatorio?
E, se vogliamo, non è forse altrettanto diffamatorio (visto che, stando al Garzanti, una delle definizioni di diffamazione è “calunnia”) dire che uno spettacolo è “di Daniele Luttazzi,” quando numerose porzioni del medesimo sono prese paro paro dai comedian meno noti in Italia – e questo non è stato chiaramente specificato al pubblico? Dire che si tratta di citazioni crea una sorta di impunità speciale di cui non sono a conoscenza? Perfino Franco Zeffirelli, Suso Cecchi d’Amico e Paul Dehn, quando scrissero La Bisbetica Domata, nel poster americano misero il geniale, “Si ringrazia William Shakespeare senza il quale sarebbero rimasti senza parole.” Questa sì che è una strizzatina d’occhio!
Ma proseguiamo. Sempre nell’intervista de Il Fatto, lei sostiene che, “Estrapolare battute da un testo dicendo ‘Sono simili, quindi è plagio’ è una solenne baggianata.” Qui ho iniziato a perdermi. Innanzitutto, se le occorreva una battuta “come esempio di battuta che la tv trasmetterebbe tranquillamente,” perché dirne una di Carlin (senza rivelarne la fonte) anziché inventarne una di sana pianta? Ma a parte questo, durante il suo recital, George Carlin dice quella battuta al di fuori di un qualsiasi contesto, non collegata a quanto detto prima né a quanto detto dopo. Il fatto che lei l’abbia messa in un contesto, non la migliora né la peggiora affatto: è una battuta che funziona in qualsiasi contesto perché è una riflessione così, volante (okay, va bene: forse sarebbe sconveniente farla durante un campionato di apnea – in tal caso dico in quasi qualsiasi contesto).
Lei prosegue, “Ogni modifica tecnica, anche minima, può quindi migliorare una battuta. Ecco perché, se sai che il suono “k” è particolarmente comico (come spiega Neil Simon: “Cocomero fa ridere. Pomodoro non fa ridere” ) ti basta sostituire “mosca” a “falena” per potenziare di gran lunga l’effetto.” Vero. Ma questa è una variante della traduzione. Lei forse ha migliorato la battuta in italiano, non la battuta in sé. Ecco perché George Carlin ha scelto con cura il termine “moth” (falena, o tarma) anziché “fly” (ossia mosca): a parte che moth fa decisamente più ridere di fly, in inglese “volare” è anche fly, e quindi si sarebbe creato un bisticcio di parole tra fly-mosca e fly-vola. Senza contare che il gesto di Carlin si avvicina molto di più a quello del volo arzigogolato di una falena che a quello in genere più lineare di una mosca.
Naturalmente non sono qui per discutere ruoli attanziali, isotopie più distanti, orientamenti semantici ed altre cose che potrebbero far pensare ai lettori che io sia veramente colto. Anzi, credo che oggi sia la prima volta che io abbia scritto “attanziali,” quindi mi sento una persona migliore. Ma ho divagato.
Gli adattamenti da una lingua ad un’altra sono fondamentali (chi non ricorda la battuta vaudevilliana di Frankenstein Junior, “Lupo ululà e castello ululì”? Fosse stata tradotta parola per parola sarebbe risultata, “Lì cantropo e là castello.” Molto meno efficace, ne convengo); io stesso ho segnalato alle Formiche (e poi Cicale) due volte la stessa battuta – combinazione di George Carlin, combinazione citata da lei – sulla religione che ha convinto che esiste un essere nel Cielo… Immagino lei la conosca. La prima volta che sentii Carlin dire questa battuta fu durante un montaggio rapido visto negli studi della CBS, e la tradussi così come la disse (battuta 611 ne Le Formiche e le Cicale, se volesse controllare – mi rendo conto peraltro che abbiamo rischiato un caso simile a quello di Bonolis, in quanto noi abbiamo messo questo mini-monologo nel 2003, e lei lo aveva già detto l’anno prima. Ci è andata bene); poi sentii Carlin dire la stessa battuta in un concerto, ma in versione ampliata, ed ecco che infatti è riapparsa come battuta 1721. Il suo contributo, Professor Luttazzi, è stato quello di sostituire a “soldi” “l’8 per mille.” Più preciso che “soldi,” ne convengo, ma del resto qui in America non abbiamo l’8 per mille.
Ora, contesto o non contesto, citazione o meno, quello che lei dice nei suoi spettacoli mi sembra un tantino più che un calco. Come lei stesso ha specificato, “l’aggiornamento di una battuta generica (calco) è già un potenziamento.” Mi corregga se sbaglio – ed io sbaglio spesso, ne sono conscio – ma non mi pare che né la battuta di Carlin sulla falena né tanto meno quella di Dio facciano parte del reame delle battute generiche – anzi. Così come quelle di Chris Rock sulle ragazze che non vogliono praticare sesso orale, di Robert Schimmel sull’eiaculazione precoce, di Eddie Izzard su Gesù tra i dinosauri, del cartone animato Dr. Katz su Gesù ed i suoi addominali, del The Drew Carey Show e del bacio ed il tubo digerente…
Vede, ho letto sul suo sito: “Da anni, Luttazzi organizza una ‘caccia al tesoro’: dissemina qua e là indizi e citazioni di comici famosi, e i fan devono scoprirli.” Ora, indizi e citazioni sono appunto, indizi e citazioni: un segno, indicazione o segnale i primi, una menzione, segnalazione le seconde (a meno che non si voglia parlare di citazioni per plagio o per danni – ma non è compito mio affrontare questo discorso). Indizi e citazioni lasciano pensare appunto ad una mezza frase, ad un termine preciso – non ad un’intera routine.
Lei prosegue, “Questo escamotage nacque come esigenza legale dopo il processo Tamaro: il pretesto delle querele miliardarie, infatti, è che quella di Luttazzi non è satira, ma volgarità e insulto.” Da questo ne ho dedotto che la sua strategia sembrerebbe quella di ribattere ad un’accusa di volgarità ed insulto con un possibile reato di plagio. Il mio avvocato mi avrebbe suggerito un’altra strada, ma de gustibus…
La giustificazione di questo escamotage è – sempre dal suo sito: “Facevano così anche contro Lenny Bruce e Lenny Bruce, per difendersi, cominciò a inserire nei suoi monologhi brani di autori satirici famosi. Vinse così alcuni processi dimostrando che il brano tanto volgare di cui lo accusavano, in realtà era di Aristofane!”
Del fatto che Lenny Bruce inserisse brani di autori satirici famosi non ci sono poi così tante notizie – esiste il fatto certo che la difesa di Bruce nel processo del 1962 paragonò il comedian ad altri satirici quali Aristofane, Rabelais e Jonathan Swift.
Ammettendo comunque il fatto che Bruce usasse Aristofane, c’è tuttavia una fondamentale differenza, tra lo “stratagemma Bruce” e lo “stratagemma Luttazzi:” Lenny Bruce usava autori il cui lavoro era nel Pubblico Dominio, ossia autori di “opere letterarie e dell’altre produzioni dello spirito o dell’arte, le quali, dopo un certo tempo determinato dalle leggi, cessano d’esser la proprietà degli autori o de’ loro eredi.” (dal Dizionario dell’Académie Française, tradotto da Alessandro Manzoni – anche questa è una citazione!)
A parte Bill Hicks e George Carlin e (fortunatamente) pochi altri, lei cita autori vivi e vegeti e nel pieno possesso dei loro diritti d’autore. Peraltro, mi sono permesso di contattarne alcuni, in questi giorni – visto che sono direttamente o indirettamente interessati, ed alcuni sono anche degli amici.
Ma ho divagato di nuovo.
Sul suo sito si conclude con, “La cosa col tempo è diventata una strizzatina d’occhio ai fan: la caccia al tesoro. Scoprire le mine. Una complicità fra appassionati di comicità, come nel jazz quando Fred Hersch inserisce in una improvvisazione una frase di Monk: chi se ne accorge entra a far parte di un circolo di eletti.”
Una caccia al tesoro credo debba avere il gusto, appunto, della caccia – non del fatto di guardare una cosa e dire, “Lì c’è un tesoro, lì un altro, lì un altro, lì un altro ancora…” Dov’è il divertimento, in questo caso?
E, per ripetere le sue parole: “come nel jazz quando Fred Hersch inserisce in una improvvisazione una frase di Monk.” Lo dice lei stesso. UNA FRASE. Non un’intera routine di cinque minuti – a quel punto, il contesto va a farsi benedire.
Il video Il meglio [non è] di Daniele Luttazzi non è affatto diffamatorio: è informativo. Sarebbe come mettere in fila tutte le gag “prese a prestito” nei film di Paolo Villaggio e Neri Parenti (quasi ogni gag visiva dalla serie La Pantera Rosa, il binocolo, la palma di Top Secret!, lo specchio de La Guerra Lampo, la bomba a mano nella manica da Il Grande Dittatore, etc.): dov’è la diffamazione?
Con modestia lei dice che si sente “come un professore giudicato da un branco di ripetenti.” Ma se lei ha detto che sono anni che cita le battute di altri comici, ossia le ripete, questo non rende ripetente anche lei? (uno strepitoso giUoco di parole in dirittura d’arrivo! Oggi sono particolarmente in forma)
Lei, nell’articolo su Il Fatto dice che, per parlare di questo pasticcio, “un po’ di competenza però non guasterebbe.” Ora, con un pizzico di superbia io credo di poter dire di avere un tantino di competenza, sull’argomento, e siccome non ho un granché da perdere, mi permetto di scriverle per chiederle (e non di accusarla, tengo a precisare): Luttazzi, potrebbe dirci CHIARAMENTE perché porzioni – e non citazioni, ma segmenti interi – dei suoi monologhi sono identiche a quelli dei comedian americani?
Per concludere, cito Blaise Pascal (e lo parafraso anche! Un colpo di genio creativo spaventoso, avrà senz’altro notato): Le chiedo scusa (e la chiedo ai lettori) per la lunghezza di questa lettera, ma non avevo tempo di scriverne una breve.
Cordialmente,
Matteo Molinari